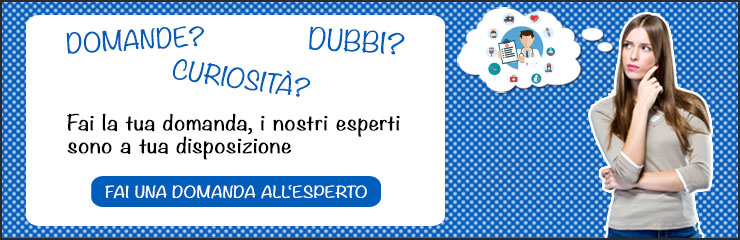Sindrome di hikikomori: alla ricerca delle cause (e delle difficili soluzioni)
Autoisolati e senza contatti reali, nemmeno con chi abita assieme a loro. Passano anni chiusi nelle loro stanze, a volte senza nemmeno alzarsi dal letto, senza una vita relazionale (e professionale)
Il suo nome (il connubio tra le parole giapponesi hiki, “ritirarsi” e komori, “stare all’interno”) ha origine nella terra del Sol Levante, quando a partire dagli anni ‘90 sono stati osservati i primi adolescenti che si sono volontariamente isolati ritirandosi nelle loro camere da letto, senza intrattenere alcun rapporto con la vita reale, nemmeno con i famigliari che abitavano sotto lo stesso tetto.
Senza riconoscere le emozioni
«I contatti degli hikikomori si sono ridotti al mondo virtuale e digitale, tanto che non riescono nemmeno più a riconoscere le emozioni degli altri», precisa il dottor Massimiliano Dieci, responsabile dell’unità operativa di riabilitazione psichiatrica specialista agli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza, nella provincia di Monza-Brianza. Negli anni successivi, la sindrome è stata osservata anche in altri Paesi e persino tra gli adulti.
Solo in Italia, la stima delle persone affette dal disturbo oscilla tra il 2,5 e il 10 per cento.
«La sindrome di Hikikomori è una grande piaga sociale, perché le persone che ne sono affette, con la loro autoreclusione, non riescono a formarsi e a sviluppare competenze sociali, relazionali e lavorative per affrontare la vita di tutti i giorni», precisa lo specialista.
Da cosa dipende
Ameno il 50 per cento degli hikikomori convive con altre patologie psichiatriche, per esempio ansia, depressione, disturbi della personalità e dello spettro autistico. Un altro motivo che può scatenare il problema è la pressione sociale: questi ragazzi non sono in grado di affrontare le aspettative sociali. In alcuni casi, alla base possono esserci anche traumi come il bullismo.
Trovare una soluzione è difficile
Gli hikikomori sono difficili da aiutare, perché hanno bisogno di azioni che non li devono forzare, ma che al contrario siano capaci di offrire loro delle alternative all’isolamento che si sono imposti. Ci sono programmi appositi che possono aiutare, alcuni anche in Italia, per permettere loro di reinserirsi nella società ridefinendo i propri obiettivi. «La collaborazione con le famiglie ed eventualmente anche con gli assistenti sociali è fondamentale: non affrontare il problema significa anche riversare sui sistemi di welfare in un prossimo futuro un peso enorme», conclude il dottor Dieci.
Ti potrebbe interessare anche:
- Emicrania: la rivoluzione dei nuovi farmaci
- Neuroginecologia: c'è una nuova scienza per combattere endometriosi, dolore pelvico e infertilità
- Antibiotico-resistenza: perché riguarda tutti noi
- Stress visivo: come contrastarlo